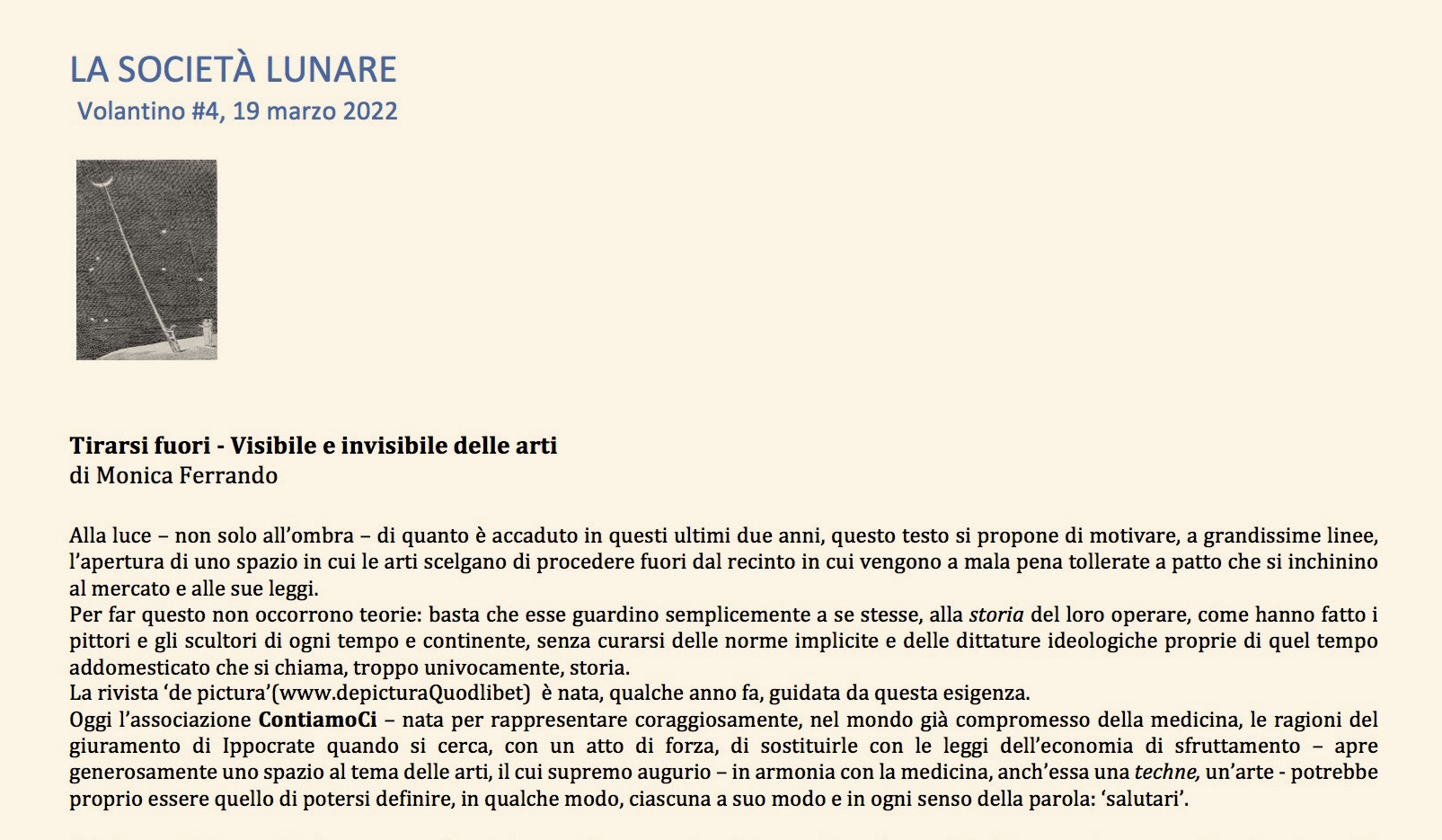. .
Alla luce – non solo all’ombra – di quanto è accaduto in questi ultimi due anni, questo testo si propone di motivare, a grandissime linee, l’apertura di uno spazio in cui le arti scelgano di procedere fuori dal recinto in cui vengono a mala pena tollerate a patto che si inchinino al mercato e alle sue leggi. Per far questo non occorrono teorie: basta che esse guardino semplicemente a se stesse, alla storia del loro operare, come hanno fatto i pittori e gli scultori di ogni tempo e continente, senza curarsi delle norme implicite e delle dittature ideologiche proprie di quel tempo addomesticato che si chiama, troppo univocamente, storia.
La rivista ‘de pictura’(www.depicturaQuodlibet) è nata, qualche anno fa, guidata da questa esigenza. Oggi l’associazione ContiamoCi – nata per rappresentare coraggiosamente, nel mondo già compromesso della medicina, le ragioni del giuramento di Ippocrate quando si cerca, con un atto di forza, di sostituirle con le leggi dell’economia di sfruttamento – apre generosamente uno spazio al tema delle arti, il cui supremo augurio – in armonia con la medicina, anch’essa una techne, un’arte – potrebbe proprio essere quello di potersi definire, in qualche modo, ciascuna a suo modo e in ogni senso della parola: ‘salutari’.
Nei decenni del secondo dopoguerra ad oggi, decenni di catastrofe politica, ambientale e sociale, l’arte non ha smesso di scriversi con l’A’ maiuscola. Nonostante la promessa hegeliana del suo superamento e della sua scomparsa a favore del dispiegarsi dello spirito in tutta la sua occidentale messianica potenza, essa ha goduto di una proporzionale, maiuscola presenza. A renderla più massiccia è la globale pianificazione di grandi musei-contenitori, mentre a legittimarla è il compito ‘sociale’ ad essa assegnato dalle istituzioni, mediante il quale l’Arte si fa portatrice autorizzata di istanze critiche che attingono con disinvoltura ai contenuti della lotta di classe degli anni ’60, articolati nelle rivolte anticoloniali, antirazziste, studentesche, femministe, ambientali ecc..

Quei problemi, che sono ancora i nostri, dall’Arte hanno ricevuto, con il pretesto di una maggiore comunicabilità ed efficacia di denuncia, una imponente quanto impropria estetizzazione. Una estetizzazione che ha funzionato da paradossale, indispensabile anestetico, assolutamente provvidenziale al progressivo saccheggio del mondo naturale e alla sistematica distruzione del paesaggio, condizione della sua mirata valorizzazione economica. L’estetizzazione sarà la pop-ulistica dichiarazione dei diritti dell’apparenza, dello schein, secondo teorie che privilegiano estetiche della recezione e dell’effetto, dirette più o meno esplicitamente ma fermamente, contro quello statuto dell’opera in cui poteva pericolosamente annidarsi ogni possibile resistenza critica all’alleggerimento e all’estetizzazione integrale e tecnologica in corso. Il progetto, forse in buona fede e forse no, già approvato da autori da cui ci si sarebbe aspettati un atteggiamento di critico sospetto, riceverà nel corso dei decenni continue benedizioni teoriche.
Invece di lasciare all’opera quella sospensione del concetto che, garantendone il legittimo statuto di apparenza, ne costituisce l’intrinseca, imprevedibile e incontrollabile libertà; invece di lasciare che l’urgente istanza politica possa trovare nella mediazione della parola terreno comune di sobria e seria riflessione, trasformazione e azione; ecco invece apparire il docile ibrido tecnologico di entrambi. L’inarrestabile processo di estetizzazione è stato infatti intentato tanto all’una (l’opera) che all’altra (la politica), con l’intenzione di alterarne la natura per programmare, al loro posto, la funzione pubblicitario-messianica del capitale. L’uso indiscriminato, propagandistico e ludico dell’immagine ha determinato tanto la banalizzazione, spettacolarizzazione e neutralizzazione dell’una (l’opera) che lo studiato, efficace e permanente antidoto dell’altra (la politica).
La maschera politica e sociale, che l’Arte detta contemporanea ha compiutamente indossato negli ultimi decenni, ha funzionato da macchina di svuotamento, nelle menti delle generazioni più giovani, di quei contenuti di critica radicale ancora presenti negli anni ’60 in alcuni esponenti dell’Arte Povera. Si pensi a Carla Lonzi, la brillante allieva di Roberto Longhi, e alla sua decisione di abbandonare la critica d’arte entro un sistema dell’arte che, senza rivedere il suo connaturato maschilismo, stava proprio allora indossando la maschera ipocrita di una ‘denuncia assistita’, cioè perfettamente innocua, del mercato. Si pensi a Emilio Prini che, col suo ‘tirarsi fuori’ denuncia profeticamente la presenza/assenza dell’artista entro un sistema che avrebbe speculato, come qualsiasi altra forma di spettacolo e intrattenimento, ma in negativo, sul supposto e costruito carisma del personaggio-artista come sostituto dell’opera.
Che la critica al mercato, l’impegno politico o sociale dell’Arte fossero una maschera lo rivela la situazione che da due anni si è imposta in gran parte dell’occidente. Nessuna voce si è levata da parte della politicizzata e socialmente impegnata sul fronte dei diritti ‘arte contemporanea’. Nessuna denuncia della macchinazione politica di cui sono divenute ostaggio persone che non accettano l’omologazione forzata. Nessuno, dei compunti operatori coinvolti nei vari progetti museali, ha avuto il coraggio, smascherando l’accaduto e l’accadere incessante dell’ingiustizia discriminatoria, di compromettersi con posizioni personali scomode. L’insolente protagonismo d’artista si è fatto, per l’occasione, cautamente mite e rispettoso.
Il timore dell’esclusione da un mondo che ha le sue inflessibili leggi – non dissimili da quelle che governano il capitale: cioè in ultima istanza commerciali – impone infatti un comportamento di fatalistica conformità. L’eventuale, o dovuta, reazione all’enormità di imposizioni inique quanto illogiche, devastanti quanto disoneste, ipocrite quanto illecite, si è limitata, e si limita, a una circospetta e luttuosa accettazione della fatalità virale come generico effetto del sistema di sfruttamento, che si evita accuratamente di mettere in discussione.
Quella trasgressione sbandierata e ammantata di preteso anarchismo, teorizzata e agita secondo un sensazionalismo mediatico divenuto immediatamente maniera, pronto a lucrare successi economici assicurati dalla sua scala globale, si è dimostrata finta. Da cavalcare, senza rischiare conseguenze di esclusione dal sistema, non le resta che la protesta ecologico-ambientalista; oppure quella della discriminazione razziale, la cui ennesima operazione di colonizzazione mediante selvaggio reclutamento estetico delle minoranze discriminate, è stata recentemente smascherata (John McWhorter, Woke Racism, 2022).
Questa, così brevemente riassunta, è comunque storia nota. Vorrei invece portare la riflessione sulla dialettica tra visibile e invisibile, che riguarda le sfere che sono qui in questione: l’arte e il potere. Basterà solo aggiungere che ora il potere non ha temuto di rendersi visibile. Questa sua visibilità, cui l’Arte seguiterà a fare da servile rispecchiamento, mira a rendere invisibile la sfera delle arti. Mai, come da XIX secolo in poi, arte e politica sono risultate indissociabili: il nesso tra questi due ambiti è proprio la struttura che hanno in comune, la dialettica tra visibile e invisibile.
Alle arti si è chiesto, per prima cosa, di costituirsi come ‘arte’, di diventare cioè un’astrazione invisibile, tradendo l’impostazione di coloro che per primi, in occidente, hanno preso a ragionare su questo fenomeno dell’umano, i quali si sono ben guardati dal parlare di ‘arte’, preferendo invece parlare di ‘arti’, al plurale (Cennini, Vasari, Bellori, ecc). E’ in questo modo, tramite un’astrazione, che si è siglata la sua sudditanza alla filosofia accademica. Solo come ‘arte’, infatti, le ‘arti’, snaturandosi, possono partecipare alla storia. Esse – che come ha mostrato Kazimir Malevic stanno nell’indistinzione tra ozio e lavoro – avranno allora rinunciato al loro potenziale misterioso, legato alla preistoria, al divino, all’irrapresentabile, all’anima, alla memoria, al sogno, alla dimensione infinita e non quantificabile del tempo. A ciò di cui sono state custodi: l’insorgenza, sempre a noi contemporanea, dell’homo poeticus, venuto prima di ogni scrittura.
Il rapporto ritenuto ‘necessario’ delle arti con la storia di cui esse fanno anche estrinsecamente parte, deve essere più attentamente considerato: specie se teniamo presente il famoso pensiero di Aristotele, secondo cui la poesia è superiore alla storia perché questa tratta di cose già accadute e quella invece di cose che potrebbero accadere. Oppure quest’altro, il pensiero guida di Alberto Giacometti: “si erge davanti a me tutta l’arte del passato”. Solo in quanto organo servizievole della storia l’arte infatti potrà: o “abolirsi senza realizzarsi” (come Debord diceva dei Dadaisti); o “realizzarsi senza abolirsi”, (come lo stesso diceva dei Surrealisti); oppure, come si sarebbe riusciti a fare con qualche successo, se osserviamo l’attività frenetica e gli esiti commerciali dell’arte contemporanea, sia “abolirsi” che “realizzarsi”.
Il contenuto intrinsecamente politico di questa realizzazione à la Hegel, prono alla filosofia della storia di un mondo che mira alla disabilitazione progressiva del rapporto poetico dell’essere umano con physis, con la natura, per ridurlo a macchina obbediente di una legge reificata che lo trascende, ha fatto sì che essa si conformasse in modo totalmente acritico al nuovo ordine del mondo, di cui appare come la messianica, parodica, ipocrita portatrice.
Cosa dava fastidio nelle arti al plurale, propriamente? Forse un modello di lavoro come poiesis, guidato con naturalezza da un nomos comune, musicale, senza divisioni reificanti e discriminatorie? Forse il loro indubbio, autonomo, ‘anarchico’ rapporto con la dimensione invisibile? E’ stato Pavel Florenskji, nel secolo XIX, a mostrare, per esempio, come la pittura non potrebbe affatto esistere senza essere lavoro materiale con precisi materiali e strumenti per dare nondimeno alla luce il visibile. Cioé senza avere un intimo rapporto con l’invisibile. Non è paradossale, in apparenza? L’arte del visibile è tramite dell’invisibile; lavora con l’invisibile, è, in certo qual modo, l’invisibile nella sua qualità accessibile allo sguardo. In questi termini, rende visibile una ontologia dell’invisibile.
Due esempi si possono portare a questo proposito:
La Madonna del Parto di Piero dipinta per Monterchi: ogni pretesa e teorizzata autonomia estetica abdica dinnanzi a questa rivelazione dell’invisibile che costituisce il tema proprio dell’affresco. Dentro un sensibile pittorico illeso da ogni ombra di soggettivismo artistico, eppure appartenente a un orizzonte di devozione preciso, anche se virtualmente riservato a ogni immagine, immagine e opera, pur distinte, si coappartengono: l’opera va oltre se stessa perché offre l’immagine di un invisibile. Per questo essa, nel largire la sua potenza invisibile, custodisce, con virtù esemplare, il silenzio fecondo dello sguardo.
La pittura e la scultura di Alberto Giacometti: continuo confronto con la dimensione dell’invisibile fino allo sfinimento, poiché, egli dice a Isaku Yanahiara, “nell’opera deve esserci uno sguardo che risponde”, “qualcosa che nasce soltanto nel momento in cui viene osservato”. E’ come se in Giacometti ad apparire fosse l’insorgenza di un operare ancestrale, presente in realtà in ogni opera, in cui il problema di realizzare o di abolire l’opera risulta un falso problema, dettato dalla contingenza storica e solo come tale, cioè più che altro in termini culturali e sociologici, tematizzabile. Nell’opera delle arti, come Giacometti e molti altri pittori e scultori tacitamente hanno mostrato anche nel corso del secolo breve e probabilmente sempre mostreranno, non si tratta di decidere né di calcolare a freddo strategie estetiche, ma di accogliere e donare. L’unica cosa che alla luce di tali esempi si abolisce come da sé è il preteso significato di teorie, ideologie, petizioni di principio, legittimazioni provenienti da larvate filosofie della storia in cerca di pubblicitario rispecchiamento.
L’esemplarità politica delle arti è dunque una potenza innata ad esse come lo è all’umano, a misura della serietà ossessiva con cui vengono perseguite, che non può essere sacrificata, pena la perdita – funzionale all’ordine del mondo che si cerca di imporre – della natura umana. Cosa meglio delle arti all’opera custodisce l’elemento indistruttibile ma certo indefinibile di questa natura umana che esse stesse hanno in primis rivelato?
M.F., Vetralla, 19 febbraio 2022
PS1: Il Volantino #4 è stato stampato,distribuito e letto in pubblico nel borgo antico di Bassano in T. il 20 febbraio 2022 in occasione del nostro quinto “incontro lunare”. I nostri VOLANTINI,fino a quando non passerà l’emergenza, e il distanziamento sociale, saranno distribuiti “di mano in mano” a chi verrà a trovarci, e quindi non potrete trovarli, come tutto, specialmente ora, nei circuiti e piattaforme online.
PS 2: pubblicato online nel mese di maggio 2022